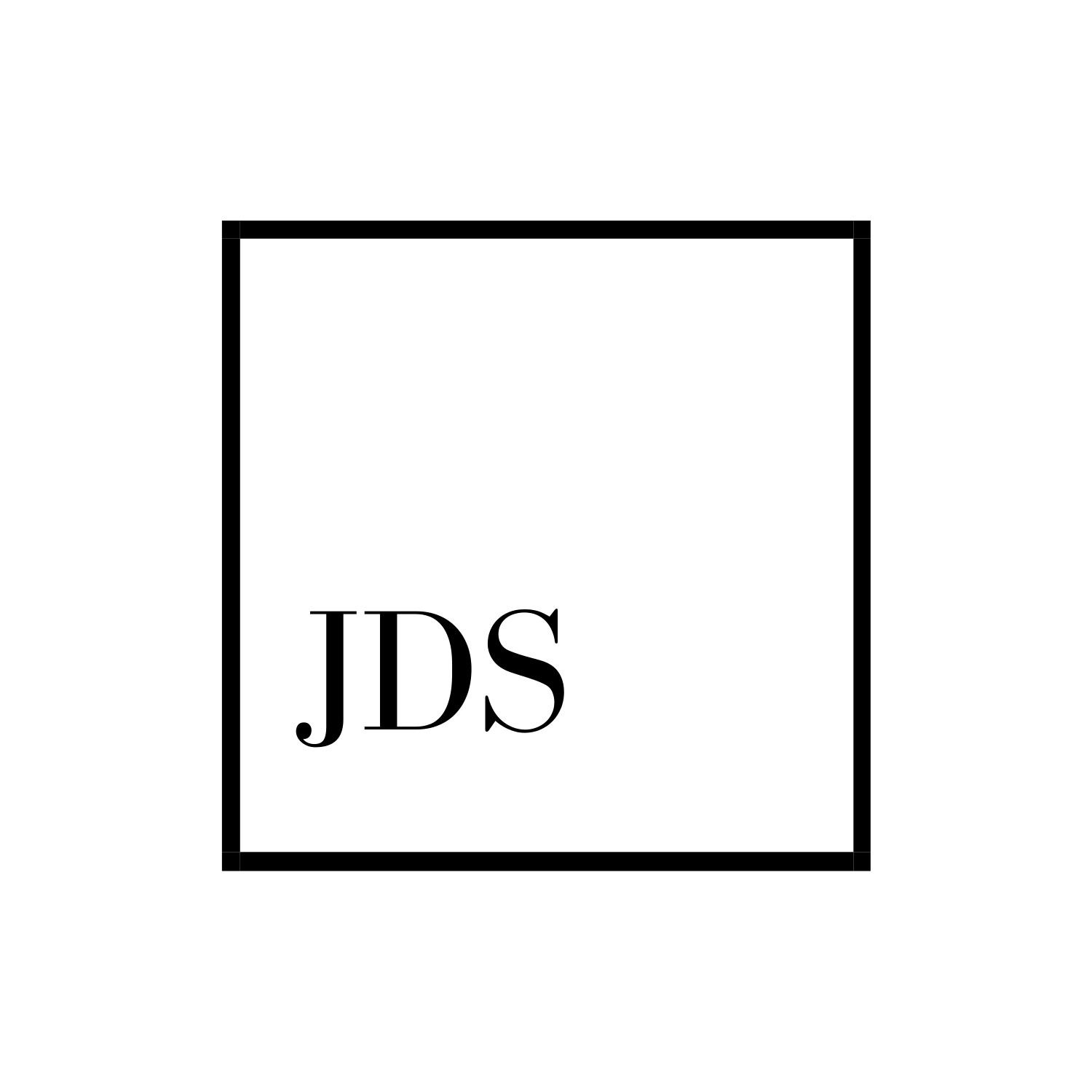“Terra, popoli, macchine” di Jeffrey Sachs
Scritto da Alberto Prina Cerai
Ci sono momenti in cui la Storia dell’umanità ha subito un’improvvisa accelerazione. Tanto verso fasi di crescita e prosperità più o meno diffusa, quanto verso la minaccia del suo totale annichilimento. Guardare alla globalizzazione – ovvero la «storia delle gloriose imprese e delle atrocità compiute dall’umanità, dei danni che a volte ci siamo inflitti da soli e delle complessità del progresso umano che avviene nel mezzo di continue crisi» (p. 15) – significa tenere conto di entrambe le facce della medaglia. Perché non esiste progresso senza conflitto. Ed entrambi sono profondamente radicati nella triplice interazione tra «geografia fisica, istituzioni umane e conoscenze tecniche» che ha dato forma all’integrazione globale.
Quello che ci offre Jeffrey Sachs, accademico ed economista tra i massimi esperti al mondo di economia sostenibile e dello sviluppo e precedente direttore dell’Earth Institute alla Columbia University, in Terra, popoli, macchineè un grande viaggio alla riscoperta della progressiva estensione del fattore umano all’intero pianeta. Una geo-storia della globalizzazione in quelle che l’autore identifica come le sue «Sette Età» ognuna con le proprie peculiarità e nessi geografici, istituzionali e tecnologici che hanno via via seminato le basi per quelle successive. Ed è significativo che Sachs manifesti fin da subito la sua convinzione: «[…] la storia ha una direzione» (p. 18). Non è una premessa banale, perché significa interpretare la Storia come le tappe di un percorso. Per scienziati e astrofisici, questa concezione che gli storici definirebbero “lineare” ha un riscontro in un dato quantificabile: la continua espansione dell’universo. E questa espansione si riflette in maggiore entropia, che altro non è che la misura della complessità di un sistema. Nell’ottica adottata dall’economista americano, dunque, è come se la globalizzazione fosse la misura della complessità dei vari fattori che hanno spinto l’umanità fino ad oggi. Non sappiamo quale sia la destinazione, ma via via affrontiamo quelli che sono gli ostacoli di un percorso fatto di progresso e conflitto, di cui l’umanità è stata sia soggetto che oggetto dell’antropocene attraverso glaciazioni, epidemie e guerre.
Quello che più sorprende nella ricostruzione fatta dall’Autore non sono tanto i contenuti e le differenze evidenti tra le diverse fasi della globalizzazione, quanto l’impressionante accelerazione impressa alla “scala” del cambiamento avvenuto a partire dal XIX secolo. In particolare, se si guarda a tre dimensioni chiave – popolazione umana totale, tasso di urbanizzazione e produzione globale per persona – si comprende come le «le precedenti Età della Globalizzazione costituirono gli essenziali fondamenti in ambito di scienze, tecnologie, governance, leggi commerciali e pura ambizione che alla fine diedero avvio all’Età Industriale» (p. 27). La scala d’azione con cui le interazioni umane sono via via divenute più integrate, e allo stesso tempo più intrusive nello spazio terracqueo, è stata amplificata dalle rivoluzioni tecnologiche, dunque geopolitiche, che hanno cambiato l’impatto dell’uomo e il suo rapporto con la geografia. Quest’ultima, lungi dall’essere superata, si è imposta come un fattore cruciale nel definire la portata della globalizzazione. Sachs ribadisce come sei fattori geografici – clima, biodiversità, malattie, topografia, disponibilità di energia primaria e di minerali – siano rimasti, nell’arco delle ere geologiche, variabili indipendenti nell’equazione dello sviluppo globale. Per molto tempo i vantaggi del clima temperato delle regioni costiere dell’Eurasia (quelle che definisce “geografie favorevoli”) hanno permesso ai popoli sedentari di avvalersi dei benefici dell’agricoltura e dell’abbondanza di risorse per strappare i primi guadagni in produttività, tradotti nel tempo in capacità innovative che hanno ribaltato gli equilibri del potere. «Un tema costante della storia», scrive Sachs, «è che i principali cambiamenti nelle tecnologie militari conducono quasi inevitabilmente anche a profondi cambiamenti nelle istituzioni politiche» (p. 48). Ogni età della globalizzazione è stata infatti caratterizzata da innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato gli aspetti centrali della vita collettiva: trasporti, comunicazioni, energia, produzione di cibo, sanità e costruzioni. Per questo potrebbe non risultare troppo sensazionalistico che il libro sia stato dato alle stampe proprio nel 2020, l’anno che con tutta probabilità passerà alla storia come un nuovo turning point. Nello scenario odierno, l’umanità sta per affrontare nuovi equilibri con almeno quattro dei sei fattori geografici accennati in precedenza – declinati nel contesto di oggi: il cambiamento climatico, lo scoppio della pandemia da Covid-19, la transizione energetica e la crescente corsa ai metalli rari – che ora stanno entrando di prepotenza nei calcoli geopolitici di tutte le potenze del pianeta. Senza contare l’impatto disruptive delle tecnologie digitali sulle nostre società e sugli equilibri di potenza globali. Guardare alle lezioni delle precedenti età della globalizzazione, secondo l’autore, può dunque aiutarci nel trovare soluzioni – che nel libro diventano veri e propri auspici – per le grandi sfide che ci attendono.
La storia dei nostri antenati – dal Paleolitico al Neolitico – ci ricorda come la natura umana sia stata forgiata nel contesto di piccole comunità, spesso conflittuali, e tuttavia già in grado di sconvolgere alcuni equilibri naturali, come avvenne con l’estinzione dei grandi mammiferi delle steppe eurasiatiche e dei nostri parenti più stretti, i Neanderthal. O di come antiche civiltà dette “idrauliche” o “fluviali” abbiano potuto sopravvivere e prosperare grazie ai favori del clima e della morfologia del territorio. Il tutto spesso scandito dalla fortuna e dal caso. Come lo fu l’addomesticamento del cavallo o degli animali da traino, avvenuto principalmente in Eurasia e Nord Africa, probabilmente la prima grande innovazione per la sua crucialità nello sviluppo economico, politico e militare: perché fu «dalle steppe che il cavallo sarebbe riemerso come la tecnologia chiave per la guerra e la costruzione di Imperi circa ottomila anni dopo l’avvio del periodo Neolitico» (p. 77).
Il cavallo, insieme all’estensione di sistemi di scrittura e ai progressi nella metallurgia, ha scandito l’età tra il 3000 e il 1000 a.C., fino alla comparsa delle quattro grandi civiltà – greco-romana, persiana, islamica e cinese – che hanno avviato l’età classica. Segnata nella prima fase da città-Stato spesso in competizione per il dominio dei commerci marittimi (“talassocrazie”) o delle risorse minerarie e agricole (“tellurocrazie”), fu poi caratterizzata da una globalizzazione di tipo politico, dal momento che gli Imperi dell’Età Classica cercavano di sfruttare la nuova forma di governance politica per diffondere tecnologie, istituzioni e infrastrutture per la prima volta su scala continentale. L’Impero romano e quello cinese Han costituirono senza dubbio l’apice dello sviluppo economico, politico e tecnologico di quest’epoca (1000 a.C. – 1500 d.C.), e probabilmente il paradigma perfetto della triade geografia-istituzioni-tecnologia: non a caso furono “benedetti” da latitudini fortunate (le zone temperate dell’Europa e dell’Asia orientale) che garantirono grande produttività dei raccolti a sistema misto e allevamento, ottime vie di comunicazione e commercio e flussi tecnologici lungo tutto l’asse est-ovest capaci di assicurare pace e prosperità nei confini imperiali. Ma ben presto questi equilibri sarebbero stati spezzati da un repentino cambiamento nei rapporti militari tra difesa e attacco. «In definitiva», riassume Sachs, «le maggiori popolazioni e le maggiori densità demografiche dell’Impero romano e di quello Han diedero loro enormi vantaggi in merito alla scala e ai risultati tecnologici, ma non li protessero dalle conquiste da parte di vicini a densità demografica più bassa – le popolazioni germaniche dell’Europa settentrionale, i conquistatori turchi del Mediterraneo orientale e le tribù nomadi delle terre aride dell’Asia centrale». Nonostante l’apertura di una fase di profonda instabilità e stagnazione in Europa, dalla prospettiva della globalizzazione l’Età Classica consegnava alla storia dell’umanità l’integrazione del continente eurasiatico, con gran parte dei progressi economici e tecnologici avvenuti nella fascia temperata definita da Nicholas Spykman come il Rimland, che ospitava tra il 1000 e il 1500 rispettivamente l’85% e il 77% della popolazione mondiale, con un ulteriore picco del 67% e 57% nelle sue sole propaggini più fortunate (cit. pp. 102, 110).
Con l’inizio dell’era post-colombiana, per la prima volta da più di diecimila anni dalla chiusura dello stretto di Bering, il Vecchio Mondo e le Americhe tornarono in contatto. E le modalità con cui questo scambio si realizzò finirono per spostare completamente l’epicentro del potere mondiale, imprimendo una direzione euro-atlantica alla storia della globalizzazione. Perché l’Europa? Un quesito che tuttora anima il dibattito accademico per spiegare la progressiva ascesa industriale, e dunque politico-militare, del Vecchio Continente a discapito dell’Impero cinese e, più in generale, di un’economia asiatica vivace e dinamica a livello commerciale tra il XV e il XIX secolo. Con la mappatura del globo e le imprese oceaniche dei grandi esploratori, si aprì l’età dello “scambio colombiano”: un flusso fatto di risorse minerarie e agricole provenienti dal Nuovo Mondo grazie all’imposizione di un sistema schiavistico tra i più brutali della storia. Sono i prodromi del capitalismo globale moderno, le cui fattezze rispecchiavano via via i vantaggi commerciali e militari europei: imperi marittimi, fondati sulla superiorità tecnologica nella navigazione e delle flotte militari, ma anche e soprattutto Stati mercantilistici che affidavano il controllo delle rotte commerciali e degli scambi extra-europei a compagnie private nei quadranti più esotici dell’Asia. Una prima forma di quel “capitalismo politico”, di intreccio tra Stato e capitale, che ancora oggi delinea il limite invalicabile della sicurezza nazionale agli attori economici. E non è casuale che Adam Smith venga costantemente ripreso dall’Autore per trasmettere lo zeitgeist dell’Età Oceanica (1500-1800). La Ricchezza delle Nazioni, oltre ad essere il fondamento della teoria economica moderna, rappresenta lo sguardo di un’intellettuale che cercava di cogliere la scala di una frattura epocale, i cui riverberi si sarebbero pienamente dispiegati nel corso dei decenni successivi, con l’ascesa dell’Occidente sul resto del mondo. Ed è in questo passaggio che la lezione di Smith sullo spostamento del baricentro economico verso l’Atlantico è particolarmente significativa per l’epoca della globalizzazione che stiamo attraversando. Perché l’estensione dei commerci prima terrestri, con le antiche Via della Seta a sancire la centralità della Cina dei Ming, e poi marittimi, con il dominio della Compagnia inglese delle Indie orientali, il contributo delle guerre intra-europee nell’innovazione tecnologica e dunque nell’assicurare agli imperi globali spagnolo, francese e britannico quei vantaggi sui potentati asiatici, alla fine rivelarono la natura estremamente diseguale di un commercio esteso all’intero globo. In questo passaggio di consegne di natura egemonica, «di fatto all’epoca di Smith [il commercio] aveva dato vantaggi a una sola parte dell’umanità – vale a dire quella dell’Europa occidentale – arrecando sofferenze agli abitanti delle Indie orientali e occidentali, che soccombettero al potere travolgente dell’Europa». Ciononostante, la globalizzazione economica ben presto si sarebbe resa responsabile «della diffusione delle conoscenze fino a divenire causa del ribilanciamento dei poteri» (p. 142), dando così adito alla convinzione smithiana che quest’ultimo avrebbe infine condotto ad un “qualche tipo di rispetto dei diritti reciproci” tra nazioni in legittima competizione per la leadership globale.
Uno scettro che l’Età Industriale (1800-2000) avrebbe infine consegnato alle potenze anglo-americane, Gran Bretagna e Stati Uniti: due imperi globali la cui egemonia – politica, economica, tecnologica nonché culturale – si è fondata rispettivamente sul posizionamento favorevole nella fase iniziale della prima rivoluzione industriale e nella fase finale della seconda e sulle due invenzioni che hanno scardinato gli equilibri: la macchina a vapore e il circuito integrato. L’intuizione di James Watt consentì il passaggio da “un’economia organica a un’economia ricca di energia”, dal momento che la sua invenzione – che nel gergo odierno definiremmo una general purpose technology – finì per travolgere ogni settore dell’economia, garantendo salti di produttività mai registrati prima. E per ritornare al quesito precedente: perché la rivoluzione industriale si innescò in Inghilterra e non altrove? Furono circostanze fortuite, oltreché dettate da fattori che rispondevano alla triade geografia-istituzioni-tecnologia: la Gran Bretagna godeva di riserve carbonifere importanti, grazie alle quali poté consolidare la sua industria estrattiva a costi decisamente competitivi; emerse come nazione e cultura depositaria dell’empirismo, del razionalismo e dell’«idea moderna del progresso umano grazie alla scienza e alla tecnologia» (p. 153), oltre che di istituzioni di mercato e di un sistema di rule of law ben sviluppati, in grado di attirare il necessario capitale privato; il fine economico, ovvero il desiderio di Watt di trasformare la tecnologia in impresa; infine, Londra era il centro di un sistema commerciale globale, in grado di assicurare alla nascente industria quel mercato di sbocco (la “scala”) per imporsi sul resto del mondo. Innescato quel meccanismo più tardi identificato dalla teoria economica come “crescita endogena”, l’Impero britannico avrebbe capitalizzato l’applicazione di quel brevetto in un circolo virtuoso innescatosi in tutti i settori economici coinvolti. E fu a quel punto che emerse, ancora una volta, un profondo divario tra il centro industriale del mondo e le sue periferie: la globalizzazione aveva creato vincitori e vinti, stabilendo una gerarchia geopolitica lungo l’asse est-ovest. Infatti, la rapida industrializzazione dell’Atlantico settentrionale finì per lasciare indietro quelle regioni che non seppero per circostanze vieppiù fortuite innescare quel meccanismo: come riporta Sachs, «nel 1820, secondo le stime di Maddison, si era già formato un divario significativo nella produzione per persona tra l’Europa occidentale e l’Asia» (p. 160). Insomma, era in atto quella “grande divergenza” descritta da Kenneth Pomeranz che avrebbe consentito alle potenze imperialiste e colonialiste europee di spartirsi il continente africano – superando, grazie agli avanzamenti della ricerca medica, la barriera microbiologica della malaria che aveva limitato l’incursione capitalista nelle regioni sub-sahariane –, di ricorrere alla “diplomazia delle cannoniere” per aprire ai commerci le riluttanti regioni asiatiche (con l’unica eccezione della “rivoluzione capitalista” del Giappone) e così alimentare una corsa sfrenata che sarebbe poi sfociata nella “seconda guerra dei Trent’anni” (1914-1945) e nell’ascesa globale degli Stati Uniti. L’apertura del “secolo americano” e l’inizio dell’età del petrolio coincise non casualmente con la rapida decolonizzazione, un fenomeno denso di conseguenze per il futuro ordine mondiale. «A partire dal 1950», scrive Sachs, «il mondo ha intrapreso un percorso di convergenza tecnologica ed economica mai sperimentata prima» e che non è mai terminata, anzi, oggi in fortissima accelerazione grazie ai progressi tecnologici indotti dalla rivoluzione digitale: «se ben sfruttata dai Paesi in via di sviluppo, la nuova ondata di tecnologie – intelligenza artificiale, sistemi smart, robotica, banda larga wireless ad alta velocità – spronerà ulteriore crescita economica convergente» (p. 183). Per dirla con Richard Baldwin, la “grande convergenza” è stata possibile per il progressivo crollo a cascata dei tre vincoli – il costo di trasferimento dei beni, delle idee e delle persone – che oggi rende obsolete le barriere tecnologiche che un tempo marcavano il differenziale d’innovazione tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo. Una nuova geografia della globalizzazione che minaccia di scardinare quell’ordine liberale costruito per rispecchiare e riprodurre la superiorità dell’Occidente a guida statunitense. E che ben si incarna nel caso più rilevante di crescita convergente, quello della Cina. L’Età Digitale, settima e ultima tappa della globalizzazione, fu il risultato di un flusso d’innovazione esponenziale avviato dalle menti più geniali del XX secolo: Alan Turing, John von Neumann e i due pionieri dei Bell Laboratories, Robert Noyce e Jack Kilby. La concettualizzazione del computer e la creazione del primo transistor moderno – unità fondamentale dei microprocessori – stanno alla base della nostra rivoluzione digitale.
Tuttavia, come dimostrano le tappe precedenti, l’apertura di una transizione di questa scala comporterà alcuni rischi per la stabilità globale. Da una parte, avverte l’Autore, queste tecnologie sembrano promettere «la fine della povertà», ma dietro al loro utilizzo già si assiste ad «un drammatico e destabilizzante aumento delle disuguaglianze economiche». Inoltre, alla transizione digitale si affianca il “grande fardello dell’uomo industriale”: la crisi climatica, oltreché la perdita di biodiversità, come conseguenze antropogeniche dell’Età Industriale. Infine, il terzo rischio, troppo spesso sottovalutato: come ci rammenta questo volume, «ogni nuova Età della Globalizzazione è stata accompagnata da un profondo riassetto del potere geopolitico e in genere anche da guerre» (pp. 202-203). E qui giace il più grande dei paradossi: in un’epoca di fragili equilibri geopolitici dovuti ad una duplice transizione – digitale ed energetica – si necessità più che mai di una cooperazione multilaterale e globale per vincere le sfide dello sviluppo sostenibile e così salvare il progresso dell’umanità dalla minaccia dell’olocausto ambientale. Per farlo, secondo Jeffrey Sachs servirà «guidare la globalizzazione nel Ventunesimo secolo» attraverso la riforma delle Nazioni Unite per rispecchiare interessi e necessità di un mondo multipolare e post-americano e il consolidamento dell’ethos socialdemocratico per guidare la transizione con un ruolo centrale della “sfera pubblica” nello sviluppo sostenibile. In conclusione, l’Era Digitale imporrà un nuovo paradigma, forgiato dalle nuove interazioni tra geografia, tecnologia e istituzioni. Lungi dall’imporre omogeneità sulla terra, tra i popoli e con le macchine del progresso, la globalizzazione ha riflettuto «il fatto fondamentale che il viaggio dell’umanità […] è sempre stato condiviso» (p. 232). Comprendere la lezione del nostro passato, come ci offre la lettura di questo appassionante volume, rappresenterebbe una buona premessa per scrivere il futuro prossimo dell’umanità.